Non so a quanti succeda, come è successo a me, di lasciare
all’università un pezzo di cuore. È stato un periodo di grandissima
libertà intellettuale, di intensa vita creativa, di scontri culturali,
di sodalizi destinati a una lunga durata e di prospettive aperte. Da allora sono successe tante cose. Ma pensando ai ragazzi che oggi vanno all’università mi domando se anche per loro possa essere una grande esperienza.
In effetti, dall’esterno, parrebbe che esista un rischio che non sia così.
L’università sta cambiando profondamente. In parte come conseguenza non desiderata di altri cambiamenti. In parte per il tentativo di riorganizzazione che è da tempo in atto. E il cui ultimo episodio è la riforma dei sistemi di valutazione della ricerca dei professori che diventa un nuovo modo di reclutare il personale docente.
Il problema che si è posto all’Anvur è semplice: come si può costruire un metodo di valutazione che sia indipendente dalle lobby e dalle cordate dei “baroni” e che sia epistemologicamente e scientificamente valido? Ne è venuto fuori un approccio algoritmico per cui i criteri si basano sulle pubblicazioni in riviste scientifiche importanti e sul loro fattore di impatto (quante citazioni hanno ottenuto da altri ricercatori). L’Anvur informa in materia sul suo sito.
Molte perplessità sono state espresse. Un criterio solo algoritmico si può hackerare. Un ricercatore troppo innovativo può essere penalizzato dalla mancanza di citazioni fisiologica per i risultati di ricerca più rivoluzionari. Le cordate si possono ricreare anche con il peer-to-peer. Le strutture editoriali delle riviste scientifiche acquistano un potere immenso anche se sono del tutto for profit. Sergio Benedetto ha spiegato a Repubblica quello che il suo gruppo sta facendo. L’attenzione per queste obiezioni è molto grande e il lavoro dell’Anvur è condotto da persone di grandissima professionalità. La profondità del problema è troppo grande.
Ma un fatto è chiaro. L’università ha bisogno di ritrovare un orgoglio per la sua ricerca e per il suo ruolo nella società. La ricerca ha bisogno di essere una prospettiva di vita per molte persone. E la società ha bisogno di ricercatori che siano anche modelli intellettuali capaci di diffondere il senso dell’apertura intellettuale oltre i confini discipliari. E l’epoca della conoscenza sta comunque ridefinendo ogni disciplina. È il momento di alimentare l’energia degli intellettuali, è il momento di liberare la loro capacità creativa. Il modo per farlo deve essere tecnicamente specchiato e umanamente intenso.
La trasformazione dell’università è in atto. È uno degli aspetti fondamentali della storia che stiamo vivendo. E ad essa va assegnata l’attenzione che merita un passaggio tanto importante.


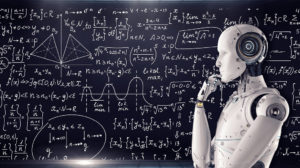



Prima di essere il cuore della ricerca, prima di essere un laboratorio di creatività e innovazione, facciamo che l’università italiana dia COMPETENZE ATTUALI che magari siano VALIDE per il mondo del lavoro?
MAI PIU’ universitari laureati in Informatica che non sanno installare Windows 7.
Anche io ho lasciato un pezzo di cuore all’università. La cultura informatica deve crescere ma l’esempio specifico di Windows 7 non è calzante. Non bisogna saper formattare un PC per avere le competenze necessarie per svolgere bene il proprio lavoro. Per altro il livello medio è a mio avviso molto basso e mina l’accesso al lavoro e la produttività.
Oltre all’informatica, le lingue devono essere più curate. Tenere corsi in (e non “di”) inglese non farebbe male. Mi sono laureato in Management Aziendale all’Università degli Studi di Perugia. Ho incontrato diverse persone che si sono laureate con me ai colloqui di lavoro, quasi tutti avevano grossi problemi con l’inglese. Mi sembra così strano che ragazzi che si siano laureati con il massimo dei voti temano test a crocette sulla lingua anglosassone. Che non sappiano usare bene il computer. Il risultato è che sono passato avanti a loro.
L’Università è un motore del nostro paese e credo debba migliorare. La mancanza di raccordo fra Università e lavoro è evidente. Un problema che ho percepito è che i ragazzi non riescono a sfruttare le cose che hanno imparato, anche se le hanno metabolizzate. Sono bravi a spiegarle ma non sanno che farci.
Un po’ come avere un coltellino svizzero ma tenerlo esposto in casa piuttosto che usarlo in montagna. Forse il nostro modello d’insegnamento, che mi sembra robusto e solido a livello teorico, non incentiva la partecipazione proattiva degli studenti. Un mio caro amico dopo l’erasmus in Germania mi disse che il loro livello di conoscenze in campo letterario era relativamente basso. D’altra parte alle lezioni si incentivavano gli studenti a proporsi, a fornire le loro spiegazioni, nonostante partorissero strafalcioni pazzeschi. Insomma una cultura più partecipativa che consente ai ragazzi di imparare partecipando o sbagliando. Nella mia esperienza personale questo mancava.
Chiudo sottolineando che parlo per quello che visto e sentito durante la mia vita universitaria, terminata oramai da 3 anni. E’ difficile farsi dei metodi d’insegnamento e delle peculiarità dato che ogni dipartimento può avere impostazioni molto diverse. Per cui prendete le mie parole a cuor leggero.
L’Italia parte con grande ritardo sul tema della valutazione della ricerca e dell’Università ed il timore e che abbiamo deciso di adottare metodologie ormai oboslete. Non a caso nei Paesi in cui si utilizzano da più di 20 anni sono in atto riflessioni per trovare modalità più coerenti e innovative di valutazione.
Avevamo la possibilità di fare un salto innovativo, imparando dagli errori degli altri. Abbiamo fatto una scelta conservatrice seguendo strade consolidate e ormai obsolete.
L’Università pubblica italiana come laureificio baronale e di casta, famigliare e parentale di dottori inutili ovvero come
centro di ricerca a disposizione delle imprese del territorio in cui insiste?
A quando una Università dell’Olio e dell’Olivo?
A quando una Università della Pasta e del Pane?
A quando una Università delle Mozzarelle e dei Formaggi?
Le università pubbliche nei territori che le accolgono si sono dimostrate dei corpi estranei alle vocazioni socio-economiche
territoriali, avverse e sorde alla produttività ed alla ricerca integrata alla economia locale.
Non si sono dimostrate volano per lo sviluppo ma solo appendice costosa e dannosa.
L’università pubblica è autoreferenziale e nutilmente costosa.
L’università generalista ha i giorni contati.
L’università della ricerca legata ed innamorata alle vocazioni territoriali è il solo futuro possibile.
Pare sia arrivata l’ora di uscire dalla convegnistica ed entrare nel vivo di una piattaforma agro-alimentare supportata e
garantita dalla ricerca universitaria.
Altrimenti, questi laureifici baronali possiamo anche chiuderli e risparmiare un sacco di denari dei contribuenti.
E se le università non producono ricerca utile alla economia reale, possiamo chiuderle, senzadubbiamente.
Il patto fra società e università pubblica è dedinitivamente rotto.
http://www.ilcittadinox.com/blog/universita-produttivita-una-difficile-conciliazione.html
Gustavo Gesualdo
alias
Il Cittadino X